|
La “Conquista Regia” (1861)
II Parlamento riunitosi a Torino all'inizio del 1861
era finalmente espressione di un nuovo regno di 22
milioni di abitanti, esteso, esclusa Roma e Venezia,
dalle Alpi alla Sicilia. Ma, sostanzialmente, l'«
unità » nazionale restava una formula giuridica, per
le radicali differenze e divergenze tra regioni
settentrionali e meridionali: due diversi livelli
socioeconomici, due diversi tipi di civiltà.
Pienamente consapevole dei gravi problemi che il
governo italiano sarebbe stato costretto ad
affrontare con l'annessione dei territori
meridionali, Cavour non avrebbe voluto sacrificare
a questa poco redditizia espansione il piano di
tranquillo sviluppo programmato per le regioni
centrosettentrionali. La campagna militare nel
Mezzogiorno fu quindi più un atto di forza dei
garibaldini che una scelta ragionata del partito
moderato al governo. Ma della difficoltà dei
rapporti con il meridione della penisola si erano
resi conto anche i « mille » sbarcati in Sicilia
l'11 maggio 1860, scandalizzati dalle sconcertanti
reazioni delle masse popolari, così poco sensibili
agli ideali del riscatto nazionale. Fatto è che per
la quasi totalità delle popolazioni meridionali,
termini quali « Italia unita », « patria libera e
indipendente » non erano che semplici espressioni
verbali. Unica forma di « libertà », intellegibile
da una massa abbrutita dal sottosviluppo economico
e da un asservimenlo sociale ancora feudale, era
quella che promettesse l'emancipazione dalla miseria
e dalle angherie dei potenti. Confortati sulle prime
dai proclami « rivoluzionari » garibaldini, i
meridionali credettero di poter identificare il loro
concetto di libertà con quello dichiarato dai
piemontesi, ma l'alleanza rapidamente instauratasi
tra aristocrazia terriera meridionale e borghesia
conservatrice settentrionale avrebbe frustrato ben
presto ogni loro speranza.
L'atteggiamento verso il Meridione è in questo
periodo il banco di prova per gli orientamenti
politici dello Stato unitario: mentre nelle
intenzioni di Garibaldi e dei democratici,
protagonisti della « rivoluzione » meridionale, il
Sud avrebbe dovuto avere un assetto amministrativo
attento alle particolari fisionomie regionali, per
Cavour e le forze politiche moderate era
irrinunciabile l'immediata ed incondizionata
annessione. L'11 ottobre del 1860 il governo
otteneva l'assenso del Parlamento ad indire in tutto
il Sud gli appositi plebisciti, che, tenuti a 10
giorni di distanza, il 21, si espressero per
l'annessione a maggioranza assoluta. La battaglia
era così vinta dai moderati, subito preoccupati di
improntare la loro politica a princìpi di rigido
centralismo. Via via estese ai nuovi territori,
nonostante l'opposizione spesso vivace delle
popolazioni, le leggi piemontesi imposero al resto
d'Italia il sistema giuridico ed amministrativo
ricalcato a suo tempo sul modello francese, senza
preoccuparsi, come invece sarebbe stato opportuno,
di apportare le modifiche necessarie ad integrarlo
con gli ordinamenti vigenti nelle altre regioni del
paese. « Tanto più che le province meridionali —
sosteneva Crispj— erano di gran lunga più progredite
di quelle del Nord in materia di codici e di
amministrazioni ».
Una soluzione federalistica, come aveva ad esempio
proposto il Cattaneo, avrebbe permesso alle diverse
esigenze locali di estrinsecarsi liberamente ed ai
problemi specifici di trovare più facilmente e
celermente soluzione. In una prospettiva più
moderata, nel 1860 i ministri Minghetti e Farini
avevano presentato, ma senza fortuna, un loro
progetto di decentramento amministrativo che
prevedeva l'istituzione di sei regioni in
rappresentanza degli antichi stati preunitari.
Simili iniziative erano però destinate a trovare la
più ferma opposizione nella maggior parte degli
uomini di governo, consapevoli della estrema
debolezza, specie nel Meridione, della coscienza
nazionale e timorosi di sancire con l'autonomia
regionale il ritorno alla disgregazione del paese.
Di qui gli sforzi del governo per unificare al più
presto l'amministrazione nazionale. Ma al di là di
ogni comprensibile desiderio di rafforzare la
compagine statale, la centralizzazione assunse
caratteri assai gravosi e contribuì a diffondere il
convincimento che l'unificazione si fosse in
sostanza ridotta ad una « conquista » operata dal
Piemonte ai danni degli altri stati, prima
indipendenti.
Particolarmente le regioni meridionali,
caratterizzate da tradizioni assai differenti da
quelle piemontesi per le diverse strutture sociali
ed economiche, lamentarono la loro subordinazione a
Torino. Iniziava aspra ed aperta la polemica del Sud
contro il governo, accusato di colonialismo e
trascuratezza; critiche ribadite anche da
osservatori politici non meridionali. Ben lungi
dall'aver goduto libertà e floridezza, il regno
delle Due Sicilie si era comunque retto fino
all'unità su un suo pur precario equilibrio, dove
il paternalismo dei Borboni era riuscito ad evitare
l'aperto scontento delle popolazioni. Ma l'«
annessione » sconvolse questo equilibrio e tutte le
contraddizioni del precedente sistema vennero
tumultuosamente a galla, mentre la politica
finanziaria unitaria contribuiva al tracollo
dell'economia meridionale. Il sistema tributario
borbonico, tra i più miti d'Europa, era stato
calibrato infatti sulle esigenze dell'economia
agricola locale: ma gli statisti piemontesi,
noncuranti del principio che un paese tollera solo
il regime tributario più adatto alla sua struttura
economica, trasferirono tale e quale nel Sud, senza
alcuna modifica, il loro intricato e gravoso sistema
fiscale, colpendo pesantemente la proprietà
fondiaria e l'agricoltura.
Prima dell'unificazione inoltre il debito pubblico
del regno di Sardegna era due volte quello del
Napoletano e della Sicilia: una legge dell'agosto
1861, unificando i debiti pubblici, scaricò sul
Meridione un onere che non gli competeva, proprio
nel momento in cui l'economia del Sud era messa a
dura prova dalla caduta dei prezzi
nell'agricoltura e nelle industrie artigiane e
domestiche. Giova ricordare a questo proposito che
non era poi tanto grande, al momento dell'unità, lo
scarto tra l'industria del Nord e quella del Sud.
Pur immobilistico e senza reali prospettive future,
l'apparato industriale creato dai Borboni aveva una
sua relativa efficienza, grazie a una idonea
politica fiscale. Ma quando la tariffa doganale
piemontese, estesa nell'ottobre 1860 alle regioni
meridionali, abbassò dell'80% i dazi protettivi
senza apprestare i provvedimenti necessari a
permettere un passaggio indolore da un sistema
tributario all'altro, la già asfìttica industria
meridionale fu definitivamente travolta.
Accanto a queste specifiche accuse risuonarono
frequenti nel primo decennio postunitario i
rimproveri per la diffidenza e la superiorità
ostentate dai « conquistatori » nei confronti delle
popolazioni del Sud, escluse a priori da appalti,
uffici, decisioni operative, tutte monopolizzate da
centri direzionali settentrionali.
Il problema era aggravato dalla reciproca ignoranza
e ci sarebbero voluti decenni per superarla almeno
parzialmente. Rinchiusi nel limbo dell'isolamento
borbonico i meridionali avevano ignorato pressoché
tutto della comune patria; non diversamente dai
concittadini del Nord ancora incapaci, per
disinformazione, di soddisfacenti analisi ed
interpretazioni della realtà meridionale. Il
Mezzogiorno, per la maggior parte di questi « altri
» italiani, era sempre l'antico « giardino delle
Esperidi » della retorica classicista, intristito
da un secolare malgoverno ma pronto a rifiorire,
materialmente e spiritualmente, al soffio
rigeneratore delle libere istituzioni civili. Un
sogno destinato alla più triste disillusione. Ma
finché durava, e durò a lungo, avrebbe impedito che
i problemi del Mezzogiorno fossero considerati con
ottica realistica, l'unica dalla quale poteva
prendere avvio un appropriato programma di riforme.
Tra Reazione e Rivoluzione (1861 –
1866)
Lo scotto da pagare per la fortunosa e frettolosa
unificazione nazionale fu in buona parte costituito
dalle ribellioni e dai tumulti nelle province
meridionali, già serpeggianti nel corso del processo
unitario, poi proseguiti per più di un lustro.
Per interpretare correttamente il valore e la
funzione delle sollevazioni rurali meridionali, che
tra il 1860 e il 1866 ondeggiano ambiguamente tra
genuini impulsi rivoluzionari e rigurgiti
reazionari, bisogna tener conto delle particolari
caratteristiche dello strato sociale, nel nostro
caso la massa contadina, di cui esse presero vita.
Una plebe vessata e sfruttata, prigioniera del
sottosviluppo economico, analfabeta, fortemente
influenzata dal clero filoborbonico, non era certo
in condizione di poter comprendere, né tanto meno
condividere, le istanze liberali e nazionali che
muovevano i patrioti del Nord. La sua rivolta —
facilmente strumentalizzabile da chiunque sapesse
far scoccare la scintilla al momento opportuno — si
esprimeva ed esauriva soltanto con esplosioni di
furore contro il « padrone » del momento e contro i
suoi simboli. Si manifestava col saccheggio delle
case benestanti, l'occupazione delle terre,
l'incendio del municipio, dei ruoli delle imposte e
dei registri catastali. Inefficace quindi e rapida
ad esaurirsi.
Ma senza l'appoggio di questa massa tumultuosa
difficilmente l'impresa di Garibaldi nel Sud
avrebbe conosciuto il successo che le arrise. La
plebe rurale è pronta alla lotta contro il Borbone
anche se gridando « viva l'Italia » si richiama a
rivendicazioni concrete, all'abolizione dei dazi e
delle imposte, alla distribuzione delle terre
soprattutto. Le bande di contadini che si pongono al
seguito dei garibaldini sono persuase di aver
trovato nel « generale » colui che le aiuterà a
riscattarsi dalla vecchia classe feudale-borghese. E
Garibaldi all'inizio sembrò venir incontro alle loro
aspirazioni: il 2 giugno 1860, con decreto davvero
«rivoluzionario», ordinava la ripartizione delle
terre demaniali mediante sorteggio tra tutti i
capifa-miglia contadini che ne fossero sprovvisti.
Ma il sogno è di breve durata che presto, conclusasi
l'alleanza con i proprietari terrieri locali,
saranno i garibaldini stessi a reprimere
severamente il moto insurrezionale contadino,
scatenatosi in eccidi e occupazioni di terre.
Vengono aboliti i decreti a favore del popolo ed è
sciolto d'autorità l'esercito dei volontari
meridionali. La disillusione è grande, la reazione
immediata: abbandonati i piemontesi, i contadini del
Sud tornano ad abbracciare la causa della dinastia
borbonica, idealizzata nel ricordo, perché
intervenga ad eliminare i soprusi attuali. Non più «
viva Garibaldi » per le vie e nelle piazze,
ma «viva re Francesco».
La ribellione divampa nell'estate-autunno 1860,
specie in occasione del plebiscito per l'annessione
del Meridione al resto d'Italia (21 ottobre).
Solo alla fine dell'anno il movimento sarà domato,
col massiccio intervento dell'esercito per piegare
regioni definite da Cavour « la parte più debole e
corrotta d'Italia », bisognosa di un rigido governo
militare ad ogni segno di eccessiva irrequietezza.
Ma la repressione non impedì che migliaia di
individui si dessero alla macchia, nel senso
letterale del termine, costituendo nelle fitte
boscaglie, allora estese in vaste zone del
Meridione, numerose ed agguerrite bande
brigantesche.
Nel triennio 1860-1863 il brigantaggio rappresenta
il maggior episodio di ribellismo interno
dell'Italia moderna, causato da motivi molteplici,
spesso concomitanti, a volte contrapposti. Da un
lato fu senz'altro lo strumento di cui intendeva
servirsi la reazione clericale e borbonica nella
speranza di sollevare la popolazione contro gli «
invasori » piemontesi e ristabilire il proprio
potere. Ma dall'altro non si può negare che sia
stato anche espressione di genuine istanze
popolari. A nuclei primitivi di sbandati del
disciolto esercito borbonico, renitenti alla leva e
disertori, ex galeotti e semplici avventurieri, si
unirono infatti gruppi di contadini spinti alla
ribellione dalla ventata rivoluzionaria che aveva
scosso l'immobilismo delle plaghe meridionali.
Da Roma, dove aveva trovato rifugio ed aiuto, l'ex
re di Napoli, Francesco di Borbone, brigava per
strumentalizzare a fini eversivi il movimento
brigantesco, introducendovi i suoi agenti ed
allettandolo con elargizioni in danaro e la
promessa dell'asilo politico in territorio vaticano.
Il 1861-62 segna il massimo sviluppo del
brigantaggio: Carmine Crocco, capo assoluto delle
bande contadine, si proclama generale di re
Francesco e inizia una serie di scorrerie in Puglia,
Calabria, Basilicata. Ovunque i paesi lo accolgono
festanti e la popolazione gli si affianca, quando
addirittura non lo precede, nell'incendiare
municipi e case di proprietari e nel far giustizia
sommaria di questi. Il tutto accompagnato dalla
celebrazione di solenni Te Deum e da calorose
ovazioni all'indirizzo del re Borbone. Né c'è da
stupirsene. Al clero i briganti appaiono come i
difensori della dinastia legittima e della Chiesa
contro le prevaricazioni dei piemontesi, liberali
miscredenti, cui non si perdonava di aver voluto
introdurre nel Sud la legislazione che secolarizzava
i beni ecclesiastici. I contadini, da parte loro,
innalzano il brigante a simbolo vendicatore delle
tante ingiustizie sofferte per mano dei
rappresentanti del potere. Una componente questa che
si è mantenuta, tipica del malessere meridionale,
fin in epoca moderna e può spiegarci la «
complicità » delle popolazioni locali con il
fuorilegge siciliano o calabrese. Il fenomeno del
brigantaggio affondava dunque le sue radici nella
disgregazione della società meridionale, come tra
l'altro non mancò di far osservare la relazione
della commissione parlamentare d'inchiesta, che nel
gennaio del 1863 era partita da Genova alla volta di
Napoli.
Tra i rimedi a lunga scadenza la relazione suggeriva
« la diffusione dell'istruzione pubblica,
l'affrancazione della terra, l'equa composizione
delle questioni demaniali, la costruzione di strade,
l'attivazione dei lavori pubblici ». Tutti quei
miglioramenti sociali necessari ad elevare la plebe
rurale a dignità di popolo cosciente. Ma in attesa
che maturassero le misure proposte, la commissione
d'inchiesta consigliava di insistere con la legge
marziale. A questo provvide la legge Pica del 15
agosto 1863, permettendo con lo stadio d'assedio
l'occupazione militare dei territori infestati dai
briganti. Nel 1866 il brigantaggio è finito come
movimento di massa: ma per domarlo si erano dovuti
concentrare nel Meridione ben 120.000 soldati, quasi
la metà dell'esercito nazionale. Né d'altra parte,
vinto il brigantaggio, erano venuti meno i motivi
d'ordine sociale ed economico che l'avevano
prodotto.
Diretta conseguenza di questo sanguinoso periodo fu
l'acuirsi della reciproca diffidenza tra le « due
Italie ». Nessuna meraviglia allora se negli anni
successivi il Meridione, specie la Sicilia, sarà
teatro di periodiche esplosioni di malcontento
popolare, spesso abilmente manovrato da clericali e
borbonici, contro i rappresentanti dell'autorità
governativa.
Ma a queste stesse masse meridionali esasperate
guardavano con speranza i primi nuclei di
internazionalisti anarchici, indottrinati da Michele
Bakunin, il rivoluzionario russo approdato in Italia
nel 1864, che aveva trovato numerosi seguaci a
Napoli e nel Mezzogiorno. Saranno i contadini
dell'Italia meridionale a dare impulso alla
rivoluzione sociale in tutta Italia, sostenevano gli
anarchici, organizzando sotto le loro bandiere la
prima opposizione popolare italiana.
Il Primo Meridionalismo (1861 – 1887)
Superato con la integrazione « fisica » delle
regioni meridionali il primo grosso trauma
postunitario e portata a compimento con l'acquisto
di Roma e Venezia l'unità nazionale, gli uomini che
reggono 1 Italia devono rimboccarsi le maniche
dinanzi alla serie di problemi che affliggono il
giovane stato « in rodaggio ». In primo luogo il
risanamento del gravissimo disavanzo della finanza
pubblica, dissestata dalle spese per le guerre
risorgimentali: il deficit del bilancio tocca le sue
punte più alte nel 1866 e solo a partire dal 1869
riuscirà a risalire lentamente la china fino al
pareggio, con una ferrea politica finanziaria che
inasprisce al massimo il sistema fiscale. Tra il
1862 ed il 1880 le entrate dello Stato raddoppiano,
ma in proporzione le regioni meridionali sono più
delle altre spremute dalla imposizione tributaria.
Il vero grosso problema del Mezzogiorno resta però
la questione della terra. Vecchio di duemila anni,
appena scalfito dalla soppressione giuridica della
feudalità, il latifondo meridionale sembra destinato
a ricostituirsi costantemente attorno ai pochi
possessori di capitali. Poco serviva infatti
dividerlo in lotti da cedere a prezzi moderati ai
contadini se questi, sprovvisti dei mezzi necessari
per culture remunerative, si vedevano prima o poi
costretti a rivenderli. La grande legge eversiva
della feudalità aveva spartito nel 1806 più di un
terzo del demanio feudale e comunale tra oltre
230.000 contadini: da allora in poi i vari tentativi
di quotizzazione della terra si riveleranno, nel
volgere di pochi anni, un fallimento.
Il nuovo stato unitario ci riprovò con la vendita
dei beni fondiari confiscati agli enti religiosi ed
alle istituzioni di beneficenza ecclesiastiche. Tra
il 1861 ed il 1867 furono incamerati e messi
all'asta, divisi in piccole quote, circa un milione
di ettari che la legge istitutiva del 1867, per
soddisfare le esigenze dei contadini poveri
desiderosi di acquistare un appezzamento,
prescriveva di cedere a pagamento dilazionato. Ma
unico risultato fu quello di favorire i possessori
di capitali e di veder conseguentemente ampliato il
numero e le estensioni dei latifondi. Inoltre, nella
generale corsa all'acquisto delle terre, la classe
agiata spese oltre 600 milioni in tutto il
Mezzogiorno, danaro distolto da più utili
investimenti produttivi per il rammodernamento
dell'agricoltura locale. Col fallire dei primi
rimedi tentati, si accrebbe da parte di studiosi e
politici l'attenzione verso i problemi del Sud. Non
sembrava logico, sopiti i tumulti generati dalla
unificazione e con tutto l'organismo nazionale in
piena attività ed efficienza, che il Meridione
continuasse a ristagnare nell'immobilismo del suo
sottosviluppo. Nasce così la « questione
meridionale », intorno alla metà degli anni 70, con
la prima saggistica preoccupata di studiare le cause
della
arretratezza del Sud e di
proporre i rimedi. Si levano le prime voci a
rivendicare gli interessi, fin qui conculcati, di
quelle disgraziate regioni e la loro denuncia, pur
se non coglie a fondo i reali termini della
questione, serve a darle una coerente impostazione.
Pasquale Villari, maestro di questa prima
generazione di meridionalisti ammonisce la borghesia
italiana che solo aiutando le plebi meridionali ad
uscire dalla loro arretratezza assolverà al suo
mandato di classe dirigente e terrà lontano il
pericolo di sommovimenti sociali. Leopoldo
Franchetti e Sidney Sennino con inchieste svolte dal
vivo, delineano le penosissime condizioni di vita
delle plebi rurali siciliane, vessate da costumanze
feudali e patti di lavoro onerosi. Giustino
Fortunato, forse il più preparato « esperto » del
tempo sui problemi storici, economici, geografici e
sociali del Mezzogiorno interviene a dissipare il
mito di una Italia meridionale naturalmente fertile.
Terre aride e coste malariche, fiumare e valli
franose, montagne brulle e piane dissestate, ecco la
vera natura del Mezzogiorno, ricorda Fortunato.
Questo meridionalismo liberale propone gli
interventi correttivi più idonei alla realtà
economica e sociale del Sud, ma non sa indicare le
misure radicali indispensabili all'effettiva
soluzione dei problemi prospettati. Ma pur nel suo
prudente riformismo rivolge una critica serrata alla
politica governativa, un aperto rimprovero che muove
dall'interno stesso del « sistema », anche per
avvertirlo che la sua solidità può essere minata
proprio dalla questione meridionale.
Già le elezioni del 1865 avevano determinato nel Sud
la retrocessione dei candidati governativi della
Destra e la parallela avanzata dell'opposizione di
sinistra, che con le elezioni del 1874 sottolineò
ulteriormente la propria affermazione. Dalla
Sinistra gli elettori meridionali, per lo più
notabili e possidenti, speravano a tutela dei propri
interessi, una politica fiscale meno oppressiva e
più prodiga di stanziamenti finanziari. Sorretta
dunque nel Sud da chi ne attendeva vantaggi
personalistici e non riforme sociali a favore della
popolazione, una volta al potere la Sinistra
liberale non seppe operare sostanziali miglioramenti
in quelle regioni. Anzi la politica del «
trasformismo » introdotta dalla nuova classe
dirigente riconfermò il Sud nella propria
subordinazione, dopo il patto intercorso tra
borghesia settentrionale e ceto proprietario
meridionale. Quest'ultimo, dietro promessa di non
veder intaccati i propri interessi di classe,
offriva al governo la sua collaborazione perché
anche nelle province del Mezzogiorno potesse
funzionare l'apparato amministrativo ed estendersi
l'influenza politica di chi a Roma deteneva il
potere. Mentre il governo è preso dalle sue
preoccupazioni di tattica parlamentare, i nodi
cruciali della situazione meridionale, questione
sociale e problema demaniale, restano irrisolti.
Sul problema della terra in particolare gli studiosi
e gli statisti più attenti richiamano l'attenzione
della classe dirigente; per un paese come l'Italia,
ancora fondamentalmente agricolo era infatti di
somma importanza tutelare le sorti
dell'agricoltura. Nel 1872 il radicale Bertani,
accennando in un suo discorso alle spaventose
condizioni di vita di gran parte della popolazione
rurale italiana, specie meridionale, proponeva una
inchiesta parlamentare sulle condizioni di vita dei
contadini e sulla situazione dell'agricoltura. Un
settore della vita nazionale sul quale, a parte
limitati tentativi di indagine pubblici e privati,
mai si erano avuti dati rigorosamente scientifici.
La commissione parlamentare, messasi al lavoro nel
1877, avrebbe presentato nel 1885 la sua relazione
offrendo un quadro non esauriente ma
sufficientemente scoraggiante. All'origine degli
squilibri socioeconomici del meridione, ribadiva
l'inchiesta Jacini, era il problema dei rapporti
fondiari: solo un sistema di interventi statali
indirizzati alla formazione di una classe di
piccoli proprietari contadini avrebbe potuto dare
l'avvio alla soluzione di tale problema.
Dinanzi alle gravissime difficoltà, dipendenti da
una specifica realtà locale, ci si chiedeva anche se
non sarebbe stato meglio, nell'interesse delle
regioni meridionali, affidare alla loro diretta
competenza la responsabilità ed i mezzi per
coordinare gli interventi più idonei. Si trattava in
sostanza di riprendere la proposta delle autonomie
locali formulata dal Minghetti e che la negativa
esperienza di un ventennio di centralismo
dimostrava ora più che sensata: troppo preso dalle
grandi questioni della difesa nazionale, della
politica estera, il Parlamento era infatti portato a
trascurare i problemi « periferici ». Ma tale audace
proposta parve a molti irrealizzabile : le
testimonianze dei meridionalisti pur contrari al
centralismo, da Franchetti a Fortunato, negavano
infatti l'esistenza al Sud di quella classe media
evoluta, indispensabile a far funzionare l'ente
regionale. Tratteggiando il quadro della corruzione
politica imperante nelle amministrazioni sottoposte
alle consorterie locali, gli avversari del
decentramento, soprattutto il Turiello, indicavano
nella autonomia un ulteriore incentivo allo
svilupparsi del nefasto clientelismo meridionale.
Occorreva al contrario tener ben saldo il potere
statale, rafforzarne anzi l'autorità per portare a
compimento quelle funzioni che le forze locali del
Mezzogiorno avevano fino ad ora dimostrato di non
essere in grado di assolvere da sole.
L’Italia di Crispi e la “Razza
Maledetta” (1887 – 1900)
II nuovo corso economico intrapreso dalla classe
dirigente e dai governi della Sinistra attorno al
1879, con una serie di interventi diretti a favorire
le industrie del settentrione, avrebbe dovuto
condurre la nazione al livello dei più sviluppati
paesi europei. Si riuscì in effetti ad accelerare il
processo di industrializzazione proteggendone
artificiosamente lo sviluppo, ma a prezzo di
negative ripercussioni negli altri settori
economici.
Per i primi venti anni di vita dello stato unitario,
nei loro rapporti con l'economia nazionale i vari
governi si erano attenuti ai princìpi del
liberismo, secondo i quali un sano sviluppo
economico deve procedere dal basso e fondarsi sulla
libera iniziativa dei produttori.
Ma ben presto motivi di prestigio nazionale ed
interessi particolaristici fecero preferire il
modello economico già attuato in Germania,
consistente in una serie di interventi « protettivi
» messi in opera dallo Stato a tutela di determinati
settori produttivi.
Propugnatore della nuova politica economica fu il
gruppo riunito attorno al « Giornale degli
economisti », tra cui primeggiava Luigi
Luzzatti. Ecco dunque che per proteggere le nascenti
industrie dalla concorrenza dei paesi stranieri
tecnologicamente più avanzati, nel 1878 gli
industriali settentrionali, i tessili ed i lanieri
tra i primi, riuscirono ad ottenere dal governo
tariffe doganali "più alte per tenere lontani dal
mercato interno i prodotti stranieri. Misura anche
utile, se limitata a brevi periodi, in Italia il «
protezionismo » divenne però pratica stabile ed
ebbe conseguenze della massima importanza per le
sorti dell'economia meridionale. Questa subì
infatti un ulteriore deterioramento non solo per il
rincaro dei prezzi dei prodotti industriali «
protetti », ma anche perché la maggior parte dei
capitali disponibili nel paese furono convogliati
verso i più redditizi investimenti nelle industrie
del Nord, sottratti quindi all'agricoltura
meridionale bisognosa di rammodernamento.
Tanto più che, desiderosi di accrescere i propri
profitti, gli industriali continuavano a chiedere
ulteriore protezione al loro monopolio sul mercato
interno. Trattandosi di importanti gruppi di potere,
dai quali dipendeva la sua stessa stabilità, il
governo cedette e si giunse alle nuove tariffe
doganali del 1887, che portarono alla denuncia
unilaterale da parte italiana del trattato
commerciale con la Francia. Stipulato nel 1861 e
rinnovato nel 1881, il trattato aveva finora
assicurato un ottimo sbocco alla produzione agricola
meridionale, che in poco tempo aveva decuplicato la
sua esportazione di vini, raddoppiato quella
dell'olio e triplicato quella degli agrumi. La
rottura del trattato, chiudendo all'agricoltura
meridionale il suo migliore, e in molti casi il suo
unico, mercato, ebbe conseguenze disastrose. Né
valse a ristabilire
l'equilibrio il dazio sul grano e altri prodotti
agricoli che si disse introdotto per « compensare »
il Meridione: se ne avvantaggiarono difatti solo i
prodotti coltivati al Nord (riso, barbabietole da
zucchero, canapa) ed i grossi agrari del meridione
che, visti incrementati i propri profitti, non
esitarono ad esprimere il « favore » del Mezzogiorno
per la nuova politica doganale.
Ma il dazio sul grano confinava l'agricoltura
meridionale ad una monocoltura estensiva,
allontanando ancor più la probabilità che venissero
operate le trasformazioni fondiarie necessarie.
Fu dunque l'economia del Meridione a pagare le spese
dell'incremento produttivo dell'industria italiana,
salito tra il 1881 ed il 1887 del 37%.
A peggiorare la situazione sopraggiungeva in quegli
stessi anni la crisi agraria.
Determinata dalle massicce importazioni di grano
americano, la crisi arrivava in Italia dopo aver
investito altri paesi europei : il prezzo del grano
scese del 30% provocando in tutto il settore
agricolo un generale crollo dei prezzi. Per
l'agricoltura meridionale le conseguenze furono
ancor più gravi dato che, per mancanza di capitali,
non era riuscita, nemmeno per i prodotti più tipici,
quali gli agrumi siciliani, a darsi una struttura
capace di produzione competitiva a livello
internazionale.
Perfetto interprete del nuovo corso politico
italiano, Francesco Crispi era frattanto succeduto
nel 1887 ad Agostino De Pretis nella carica di
Presidente del Consiglio: la sua svolta autoritaria
servì a rintuzzare con estrema durezza la protesta
popolare venuta maturando. Ma anche il movimento
politico di opposizione aveva frattanto acquistato
una sua prima organizzazone e struttura. Nel 1892 il
congresso di Genova sancì la divisione tra
socialisti ed anarchici: nasceva il « partito dei
lavoratori italiani », che nel 1895 avrebbe
assunto il nome di Partito Socialista Italiano. Sarà
proprio il timore del socialismo a favorire il
ritorno al potere di Crispi per il suo ultimo
ministero.
Anche se non con la medesima rapidità che nel
settentrione le masse rurali meridionali, grazie
soprattutto all'opera dei primi nuclei socialisti,
vengono prendendo lentamente coscienza dell'iniquità
del sistema sociale che le opprime. Sale il
malcontento popolare, soprattutto in Sicilia, dove
la rottura commerciale con la Francia ha
praticamente bloccato l'economia locale. I « fasci
dei lavoratori », moltiplicatisi in tutta l'isola,
svolgono un'opera di troppo capillare propaganda «
sovversiva » perché i latifondisti non si rivolgano
preoccupati a Crispi, gridando alla prossima «
rivoluzione ». E mentre ancora una volta la protesta
popolare si esprime nel violento tumulto, il governo
organizza una repressione in grande stile che
soffoca in breve tempo il movimento.
È questo un episodio esemplare per meglio
comprendere l'atteggiamento di insofferenza e
ribellione nei confronti del potere costituito,
qualunque esso sia, radicatosi da allora in Sicilia
più che nelle altre regioni meridionali. All'epoca
dei Fasci, per le popolazioni isolane il governo fu
solo quella entità lontana ed ostile, che aveva
respinto ogni loro legittima richiesta, cedendo ai
ricatti della classe agraria decisamente contraria a
qualsiasi riforma. Pronto da ultimo, in risposta
alle proteste all'invio di 50.000 soldati per
ristabilire l'ordine nell'isola, con ampio ricorso
alla legge marziale ed ai tribunali militari. Vero è
che nello stesso tempo la medesima repressione si
esercitava contro i lavoratori in rivolta delle
regioni centro-settentrionali, ma solo nel Meridione
le contraddizioni della formula di governo in atto
si manifestarono in tutta la loro intensità ed
ampiezza.
Ai troppi scontenti, gli statisti ligi agli
indirizzi governativi ribattevano che, tenuto conto
della disperata situazione in cui si trovava il
Mezzogiorno al momento dell'unificazione, era
perlomeno da irriconoscenti lamentarsi dell'attuale
trattamento. A risultati del tutto soddisfacenti non
si era ancora giunti, ma non era nemmeno mancato un
primo decisivo avvio: strade, ferrovie, istruzione
scolastica, assistenza sanitaria, prima del tutto
sconosciute, ora cominciavano a prospettarsi come
possibilità concreta anche per quelle diseredate
contrade.
Né mancò chi tentò di giustificare in termini
razzisti la persistente inferiorità del Meridione.
Col trionfo del positivismo anche per la questione
meridionale fu elaborata una spiegazione « razionale
» e «scientifica»: la « scuola antropologica » di
Ferri, Lombroso, Niceforo non esitò a bollare di
inciviltà congenita il poveraccio nato per
disavventura al Sud, invitandolo a starsene
tranquillo in attesa del compiersi del ciclo
evolutivo che l'avrebbe forse innalzato allo stesso
livello dei confratelli settentrionali.
Il Mezzogiorno di Giolitti (1903 –
1914)
Nel 1900 sale al trono Vittorio Emanuele III, nel
1903 Giovanni Gio-litti è per la seconda volta
Presidente del Consiglio, carica che, salvo brevi
interruzioni, conserverà fino al 1914. Da accorto
uomo di governo, Giolitti comprende che, per evitare
il ripetersi di un tragico scontro tra
l'autoritarismo conservatore di molti settori della
classe dirigente e la crescente protesta delle masse
operaie e contadine, è necessario allargare le
ristrette maglie del regime liberale con una
politica più attenta alle istanze popolari. Di
conseguenza, non più sottoposte alla violenta
repressione degli anni precedenti, le organizzazioni
operaie sotto la guida del Partito Socialista e del
sindacalismo, conoscono in questo periodo un
notevole sviluppo.
Camere di Lavoro e diritto di sciopero si diffondono
anche nel Mezzogiorno, dove va sensibilmente
maturando la coscienza politica delle masse rurali :
in Sicilia con il riorganizzarsi dei contadini nelle
« leghe », in Puglia con un movimento
particolarmente combattivo. Agli agrari che invocano
l'intervento dello Stato a tutela dei loro interessi
minacciati, Giolitti risponde che solo con le
riforme sarà possibile sanare in parte il
malcontento popolare. Privati dell'appoggio
governativo nella repressione degli scioperi, i
proprietari terrieri sono spesso costretti a
concessioni a favore dei braccianti.
Ma ci voleva altro per spezzare il sottosviluppo
meridionale: anzitutto una politica governativa
veramente interessata a risolverne le sorti. Le
accurate ricerche condotte da Nitti sui bilanci del
governo, in rapporto alle finanze regionali ed alla
ripartizione delle spese pubbliche, dimostravano
invece che nel processo di sviluppo nazionale il
Mezzogiorno era costretto a sopportare i costi
maggiori. Il sistema tributario soprattutto
determinava gravi sperequazioni a danno del Sud;
l'imposta sui terreni, sui fabbricati, sulla
ricchezza mobile veniva a colpire con un onere del
tutto sproporzionato il contribuente meridionale, il
quale d'altra parte non era compensato da un
efficace programma di spesa pubblica. Di qui la
lunga e sfortunata battaglia dei meridionalisti per
una riforma del sistema tributario più rispondente
alla diversa configurazione economica delle regioni
del paese. E per far sì che canali, strade, lavori
di bonifica non si accentrassero esclusivamente
nelle regioni settentrionali. « La verità è —
sosteneva Nitti — che l'Italia meridionale ha dato
dal 1860 assai più di ogni parte d'Italia in
rapporto alla sua ricchezza; che paga quanto non
dovrebbe pagare ; che lo Stato ha speso per essa,
per ogni cosa, assai meno, e che vi sono alcune
province in cui è assenteista perlomeno quanto i
proprietari di terre ». Una politica portata avanti
anche negli anni successivi ; si calcola che nel
1910 l'Italia del Nord, con il 48% della ricchezza
nazionale, pagasse il 40% delle imposte nazionali,
contro il 32% del Meridione che di quella medesima
ricchezza usufruiva solo per il 23%.
Al ritardo del Mezzogiorno faceva riscontro il
decollo industriale delle regioni settentrionali:
tra il 1896 ed il 1908 il saggio di incremento
annuale della industria italiana è del 6,7%. Si
sviluppano l'industria automobilistica e quella
elettrica; dai 100 milioni di kilowattore del 1898
si passa ai 950 milioni del 1907 ed ai 2575 milioni
del 1914.
L'Italia non è più un paese solamente agricolo: se
nel 1900 l'agricoltura rappresenta il 51,2% del
prodotto lordo privato e l'industria il 20,2%, nel
1908 gli indici del rapporto muteranno
rispettivamente nel 43,2 e nel 26,1. Di tanta
dovizia al Meridione tocca in sorte solo l'impianto
siderurgico dell'Uva a Bagnoli di Napoli, entrato
in funzione nel 1905. Dinanzi alla constatazione del
perpetuarsi a danno del Mezzogiorno delle
sperequazioni del potere centrale, si ravviva la
polemica sulle autonomie locali. Già vedemmo come i
meridionalisti conservatori alla Turiello fossero
contrari alla autonomia amministrativa del Sud,
incentivo a loro dire del più diffuso malcostume
politico. In disaccordo con questa teoria Napoleone
Colajanni vedeva nel federalismo il mezzo per
sottrarre il Meridione alla soffocante burocrazia
centrale ed alla conseguente soggezione economica
settentrionale. Quanto alle autorità politiche non
era mancato chi alla concessione della autonomia
locale guardava come ad una sorta di valvola di
sicurezza per mettere a tacere le rivendicazioni più
urgenti del turbolento Sud. « È venuto il tempo di
costruire nel regno nuovi organi di governo » aveva
affermato De Rudinì. Ma anche i meridionalisti più
vigorosi e polemici nella difesa degli interessi del
Mezzogiorno ponevano sovente in dubbio l'utilità di
un affrettato decentramento. Nell'attuale
degenerazione del parlamentarismo, sosteneva
Giustino Fortunato, dare l'autonomia amministrativa
al Meridione, senza risanare Parlamento e Governo,
avrebbe significato favorire il proliferare delle
consorterie e del clientelismo politico. Era prima
necessario che il proletariato meridionale
evolvesse, tramite la concessione del suffragio
universale, fino a divenir cosciente degli interessi
propri non disgiunti da quelli generali del paese.
Opinione condivisa da Gaetano Salvemini, federalista
acceso dapprima, più tardi meno sicuro
dell'effettiva capacità del Mezzogiorno di porre in
atto un suo autonomo sviluppo.
Indipendentemente dalla autonomia amministrativa,
utile o meno che fosse, tutta una serie di altre
cause congiurano contro il « decollo » delle regioni
meridionali. Manca nel Sud una classe media, evoluta
al punto da saper impostare e reggere una sana
amministrazione; mancano i capitali privati
necessari a ristrutturare più economicamente
l'arretrata agricoltura locale, perché già da tempo
assorbiti nell'acquisto dei beni demaniali
quotizzati o investiti in titoli di Stato. I
superstiti capitali disponibili, quando non sono
oggetto di malversazione, bastano a malapena a
riparare parte dei danni causati dai disastri
naturali che si susseguono in quegli anni. Le
eruzioni del Vesuvio e dell'Etna, nel 1906 e nel
1910, sommergono interi villaggi e distruggono le
colture; il terremoto del 1905 in Calabria e quello
tremendo del 1908, accompagnato da maremoto,
devastano trecento Comuni e le città di Reggio e
Messina. Lo Stato interviene in maniera sporadica
ed inefficiente ed inaugura il sistema delle « leggi
speciali ». Nel 1904 e nel 1906 con le leggi dirette
a migliorare le condizioni dell'agricoltura in
Basilicata e in Calabria, nel 1905 con l'inizio dei
lavori per la costruzione dell'acquedotto pugliese
portato a termine nel 1927. Ma non era con
interventi legislativi straordinari, inefficienti e
disorganici, che la questione meridionale poteva
essere risolta; occorreva una politica globale di
riforma sociale, boicottata però dai grandi
proprietari terrieri che attraverso il controllo
delle amministrazioni locali e la conseguente
influenza sulle elezioni politiche facevano il bello
ed il cattivo tempo nel Mezzogiorno, affiancati
dalle organizzazioni mafiose giunte ad inquinare
tutti i gangli della vita pubblica locale.
Corruzione politica e clientelismo erano d'altra
parte favoriti dai metodi di Giolitti, da un lato
propenso a soddisfare le più urgenti rivendicazioni
popolari, dall'altro convinto che fosse possibile
realizzare un'autentica libertà di voto solo nelle
regioni progredite e capaci di farne un uso maturo.
Ecco dunque le manipolazioni della maggioranza
parlamentare, l'accaparramento dei voti, le vere e
proprie predeterminazioni dei risultati elettorali,
che indussero Gaetano Salvemini a ribattezzare
Giolitti « ministro della malavita ».
Anche la riforma elettorale del 1912, che
introduceva il suffragio universale maschile, pur
nel suo innegabile valore di conquista democratica,
servì a contrapporre all'opposizione di sinistra i
voti governativi delle masse meridionali. I
contadini analfabeti del Sud, circuiti o minacciati,
andarono il più delle volte ad esercitare il nuovo
diritto di voto a tutto vantaggio degli uomini
politici graditi al governo. Ma nemmeno questa
constatazione sembrò indurre il Partito Socialista
ad interessarsi più attivamente al problema
meridionale, invece di occuparsi esclusivamente
delle categorie operaie del Nord. Critica fattasi
più serrata quando si rilevò che, dinanzi
all'accentuarsi del protezionismo, il partito
preferiva attestarsi su posizioni agnostiche: forse
nel timore di contrastare, ostacolando l'ulteriore
industrializzazione del Nord, l'incremento di quel
proletariato industriale che del partito stesso
formava la forza. I socialisti dissidenti aderirono
alla « Lega antiprotezionista », e Gaetano Salvemini
giungerà ad abbandonare il partito per fondare «
l'Unità », il giornale che per vari anni sosterrà la
causa del Mezzogiorno con lucidità e coraggio. Oltre
che nel libero scambio Salvemini credeva nelle
possibilità connesse alla politicizzazione delle
masse meridionali, destinate a divenire
prota-goniste in prima persona della « questione »
del loro paese, solo se avessero acquistato una
chiara coscienza di classe.
La corruzione ed il clientelismo politico
rappresentano forse l'aspetto più umiliante, ma non
il più cospicuo dei mali del Sud durante il primo
decennio del secolo; altrettanto grave e doloroso
segno di miseria e disperazione fu l'enorme
incremento dell'emigrazione, che raggiunse la vetta
più alta, proprio negli anni di maggior progresso
del Paese.
Tra i più vistosi fenomeni nella storia dell'Italia
moderna l'emigrazione in massa della popolazione
rurale dalle regioni meridionali ha caratterizzato,
negativamente o positivamente, a seconda dei
differenti punti di vista, soprattutto gli ultimi
decenni del secolo XIX e l'età giolittiana. Ma già
nel 1861, secondo l'annuario statistico del periodo,
77.000 italiani risiedevano in Francia, 47.000 negli
Stati Uniti, 18.000 in Brasile ed in Argentina.
Anche le regioni centro-settentrionali furono
interessate al fenomeno (nel 1876 l'85%
dell'emigrazione nazionale proveniva dall'Italia del
Nord), anzi proprio in quelle province esso aveva
preso l'avvio, ma con aspetti e dimensioni assai
diverse.
Se l'emigrante settentrionale, il più delle volte,
se ne va all'estero in cerca di miglior fortuna, con
un suo bagaglio di competenze da far fruttare,
quella dei contadini del Sud, sprovveduti,
impreparati, quasi sempre analfabeti, è una fuga
disperata.
Intorno al 1876 oltre centomila italiani lasciano
ogni anno la madrepatria; verso la fine del secolo
il fenomeno aumenta di intensità, acquistando i
suoi caratteri più specifici: interi nuclei
famigliari, provenienti in massima parte dalle
regioni meridionali, spinti dall'insostenibile
situazione economica locale, danno vita ad un esodo
collettivo verso i paesi d'oltreoceano.
La crisi agraria, che sul finire degli anni '80
aveva riflesso sull'economia meridionale le sue più
disastrose conseguenze, contribuì ad incrementare
l'emigrazione dalle regioni del Sud, mentre il primo
sviluppo industriale del Nord assorbiva la mano
d'opera settentrionale in eccedenza rispetto al
fabbisogno dell'agricoltura. Al contadino
meridionale, avvezzo a cimentarsi con la natura
avversa, la fame, lo sfruttamento e la
sopraffazione, l'« America » appare come una sorta
di terra promessa. Un miraggio che vince le
difficoltà necessarie per raggiungerlo ed il forte
attaccamento ai paesi di origine.
L'America del Sud, in un primo tempo, e poi gli
Stati Uniti furono la meta principale
dell'emigrazione italiana, in costante crescita per
decenni: basti pensare che nel 1927 ben nove milioni
erano gli italiani residenti all'estero, di cui tre
milioni e mezzo negli Stati Uniti ed un milione e
mezzo rispettivamente in Brasile e in Argentina.
Le agenzie di viaggio e le compagnie di navigazione,
da parte loro, contribuirono a propagandare le
possibilità di lavoro ben remunerato offerte dai
paesi esteri; e realizzarono ingenti guadagni con il
trasporto degli emigranti, giungendo ad organizzare,
in collegamento con gli appaltatori di braccia
umane, un vero e proprio traffico di forza-lavoro.
Tra i benefici della corrente migratoria ci fu
anzitutto l'afflusso delle rimesse in denaro degli
emigranti alle famiglie (500 milioni di lire annue
nel periodo immediatamente precedente il 1914);
inoltre l'alleggerimento della pressione demografica
in regioni sovrappopolate col conseguente rialzo dei
salari e un generale miglioramento per i contadini
dei contratti agrari. A livello di costume, il
contatto con diverse e più evolute forme di
convivenza associata portò a notevoli trasformazioni
di mentalità, all'alfabetizzazione di molti, ad una
maggiore intraprendenza e consapevolezza dei propri
diritti.
Ma accanto ai vantaggi coesistevano svariati
elementi negativi, e non mancarono di denunciarlo le
voci di dissenso levatesi nel paese. Non era con
l'emigrazione, sostenevano i suoi critici, che si
sarebbero risolti i problemi generali del
Meridione, né quelli individuali dei lavoratori
sempre prigionieri della loro condizione di
sfruttati. Il mito dell'emigrazione, sottolineavano
soprattutto i socialisti, era solo un sistema per
eludere ed accantonare i precisi impegni che il
sottosviluppo meridionale poneva alla classe
dirigente. La maggior parte dei meridionalisti
liberali, al contrario, dal Franchetti a Giustino
Fortunato al Nitti, guardarono di buon occhio
l'ingrossarsi della corrente migratoria, ricordando
ai suoi oppositori che
grazie ad essa migliaia
di individui avevano almeno compiuto un passo in
avanti sulla via della loro emancipazione.
L'emigrazione, oltretutto, rappresentava
un'apprezzabile valvola di sicurezza per l'ordine
sociale nel Mezzogiorno: o emigrante o fuorilegge,
aveva affermato senza perifrasi il Nitti, questa
l'unica scelta per il meridionale desideroso di
uscire dalla sua situazione.
Un discorso che avrebbe avuto ben presto
un'interessante connessione con le aspirazioni
colonialistiche italiane nell'Africa settentrionale,
su cui il capitale finanziario e i principali
settori imprenditoriali nazionali, alla ricerca di
affari lucrosi e di vantaggiose commesse statali,
avevano già posto la loro ipoteca. Alibi alle
effettive motivazioni imperialistiche della guerra
coloniale, conclusasi con il riconoscimento della
sovranità italiana su Tripolitania e Cirenaica,
furono le infondate asserzioni sulla ricchezza della
nuova « terra promessa », pronta ad offrire asilo e
lavoro a centinaia di migliaia di emigranti
italiani. E non pochi tra gli esponenti democratici
Antonio Labriola ad esempio, subirono il fascino del
nuovo mito, che altri, come Salvemini, con profondo
rigore ed onestà intellettuale, cercarono vanamente
di sfatare.
Il fenomeno migratorio, pure con minore ampiezza e
caratteristiche diverse si è svolto ininterrotto
fino ai giorni nostri. Nemmeno il fascismo, che
tentò di dirottare nei territori africani dell'«
Impero » la sovrabbondanza di energie umane
nazionali, riuscì a sopprimerlo; ma fu l'età
giolittiana che vide il massimo espandersi del
fenomeno, segno di un profondo e doloroso malessere
sociale.
Fascismo e Meridione (1914 – 1926)
L'intervento nella prima guerra mondiale pose la
classe dirigente dinanzi al problema di mandare al
fronte i milioni di contadini meridionali, che alla
guerra non avevano alcun interesse o che a questa si
erano dimostrati apertamente contrari. La promessa
di distribuzione di terre si rivelò più persuasiva
di qualsiasi altra misura. Per ordine dello Stato
Maggiore, ai soldati del fronte fu letta questa
dichiarazione del Presidente del Consiglio Salandra:
«Dopo la fine vittoriosa della guerra, l'Italia
compirà un grande atto di giustizia sociale.
L'Italia darà la terra ai contadini, con tutto il
necessario perché ogni eroe del fronte, dopo aver
valorosamente combattuto in trincea, possa
costituirsi una situazione di indipendenza. Sarà
questa la ricompensa offerta dalla patria ai suoi
valorosi figli ». Ma finita la guerra di tante
promesse non sarebbe restata traccia; in compenso le
masse contadine — nel Sud come nel Nord — avrebbero
subito la violenza e la sopraffazione delle squadre
fasciste, sovvenzionate e sostenute da latifondisti
ed agrari.
Il 1919 segna il culmine della crisi che nel primo
dopoguerra ha investito l'intera società italiana:
si susseguono incessanti e sempre più agguerrite le
agitazioni nel mondo del lavoro e il Meridione
contribuisce alla lotta generale con occupazioni di
terre da parte dei contadini reduci dalla guerra, di
nuovo alle prese con l'immutata miseria. Ancora una
volta il Partito Socialista, vittorioso alle
elezioni nel novembre 1919, appare impotente di
fronte al problema delle masse contadine
meridionali, mai come in questo momento chiave di
volta per interpretare e correttamente risolvere la
realtà sociale del Sud. Proprio in occasione delle
elezioni la persistente immaturità politica del
Mezzogiorno aveva dimostrato tutto il suo peso con
il favore accordato alle liste governative, alla
vecchia classe dirigente conservatrice. Col riflusso
del movimento popolare e « rivoluzionario », con il
ripiegare delle sinistre indebolite e divise, la
inattuata alleanza tra operai del Nord e
contadini del Sud propugnata dai democratici più
attenti viene realizzata, mutati gli interpreti ed a
fini reazionari, tra agrari meridionali e
industriali del Nord a sostegno del fascismo
nascente. I vecchi gruppi politici locali, privi di
contenuto ideale e di un effettivo programma
sociale, sono rapidamente assorbiti dall'apparato
fascista: manca infatti nel Meridione una vera
opposizione al regime, accettato passivamente come
situazione in fondo poco differente dalla
precedente. Ma una classe sociale vide tutelati
appieno dal fascismo i propri interessi e del regime
si fece strenua sostenitrice: la categoria dei
grossi agrari, irritati ed intimoriti dalle recenti
occupazioni di terre, dagli scioperi agricoli, dalle
crescenti « pretese » dei « cafoni ». Per questi
ultimi l'avvento del fascismo significò la perdita
delle conquiste parziali ottenute nell'immediato
dopoguerra dalle organizzazioni contadine: i
contratti collettivi che sopprimevano le prestazioni
supplementari e gli iniqui privilegi padronali; i
miglioramenti nel trattamento economico, ed infine
le leggi che riconoscevano ai contadini poveri,
organizzati in cooperativa, il diritto di occupare
terre incolte o malcoltivate. Questi nuovi diritti,
che avrebbero consentito alle masse rurali migliori
condizioni di vita ma che intaccavano i profitti ed
i privilegi dei proprietari, vennero dunque
soppressi dal fascismo. Fu questo il prezzo che il
latifondo del Sud pretese per sostenere il nuovo
regime.
Ma anche gli industriali del Nord non avevano da
lamentarsi: la politica economica e monetaria del
fascismo accentuò il protezionismo a loro favore,
dedicando al Meridione, come contropartita, le sue
grandi « battaglie»: l'incremento della
cerealicoltura e la bonifica integrale. La
«battaglia del grano » operò una trasformazione
nella economia italiana, soprattutto meridionale,
elevando la produzione annua di questo cereale, di
poco superiore ai 40 milioni di quintali nel 1870,
fino agli ottanta milioni di quintali del 1939. Dal
1925 al 1935, di conseguenza, fu possibile ridurre
del 75% le relative importazioni. Il risvolto della
medaglia fu però particolarmente gravoso, perché la
produzione agricola complessiva si ridusse,
svantaggiando a favore della coltura estensiva
granaria altre coltivazioni più remunerative.
Fatto è che la « battaglia del grano » fu condotta
in vista di più concreti conflitti ; più che al
risollevamento della agricoltura italiana mirava ad
assicurare il pane alla nazione nella eventuale
guerra cui tanto sovente andava il pensiero di
Mussolini.
Un certo successo, pur nella limitatezza dei
risultati conseguiti nel Meridione, ebbe la politica
della bonifica integrale, sotto la direzione del
sottosegretario Serpieri, partita con ambiziosi
programmi, anche a carattere « sociale », ma ben
presto ridimensionata per non intaccare gli
interessi degli agrari.
Nella sua formulazione la legge garantiva alle
società ed ai privati che facessero richiesta di
concessioni per lavori di bonifica l'espropriazione
dei relativi terreni. Se attuata, questa normativa
avrebbe permesso di sferrare un deciso colpo al
latifondo meridionale. Ma gli agrari riuniti nel «
Comitato promotore dei consorzi di bonifica », messi
in allarme dal pericolo degli espropri, insorsero
rivendicando la concessione di sussidi che
permettessero a loro stessi di dar luogo ai lavori
di bonifica. L'applicazione della legge, lamentava
un documento del comitato, avrebbe gravemente
pregiudicato i proprietari di terreni « che se pur
qualche volta sono il frutto di un retaggio
ereditario, costituiscono sempre la palpitante
testimonianza di un lavoro di varie generazioni
nate e cresciute nell'amore della propria terra ».
Di qual genere fosse stato quel « lavoro » non è
specificato.
Ma il potere di pressione degli agrari era tale che
la concessione delle opere di bonifica alle società
finanziarie fu praticamente bloccata. Sviluppata
soprattutto nell'Agro Pontino, per motivi
propagandistici, data la vicinanza della capitale,
nel Meridione la bonifica integrale non andò oltre
la fase delle prime opere pubbliche e non determinò
sensibili miglioramenti allo sviluppo economico
della zona.
Ma agli insuccessi il regime sapeva contrapporre
utilmente i suoi miti. Partono a centinaia le
famiglie di coloni verso le terre africane
dell'Impero, il dono del fascismo al contadino
meridionale diseredato. Per chi resta c'è sempre il
Duce pronto ad appuntare medaglie sul petto delle
madri prolifiche durante le sue ricognizioni
pugliesi o lucane.
L'esistenza stessa di una questione meridionale è
negata ed i relativi problemi « risolti » a livello
di roboante retorica: la statolatria fascista non
ammette nemmeno l'accenno agli specifici bisogni
regionali, il concetto di « diversità » non garba
agli intenti livellatori del regime.
Contrapponendosi al vecchio stato liberale, sempre
assente dalla scena meridionale, la demagogia del
fascismo recupera però all'ossequio parte della
popolazione del Mezzogiorno, avvezza finora al solo
bastone, non anche alla carota. È innegabile che,
nella sua incolpevole diseducazione politica, il
meridionale non guardi con eccessiva antipatia a
Mussolini, in cui fa rivivere l'antica immagine del
sovrano paternalista.
Ma ecco intervenire la cruda realtà della guerra, in
cui il fascismo precipita il paese, a spezzare
l'incantesimo.
Parallelamente all'affermarsi del fascismo, le
analisi delle correnti politiche democratiche
contrappongono, alle falsificazioni ed alla
demagogia degli schemi ufficiali, la ben più cruda
verità del permanere del sottosviluppo meridionale,
dell'incancrenirsi delle sue antiche piaghe.
Voci, che pongono chiaramente il problema ed
intravedono le sue più logiche soluzioni, destinate
però a scontrarsi col periodo meno adatto ad
ascoltare, e meno ancora a sperimentare, le loro
tesi. Nel generale sfacelo delle istituzioni
democratiche che prelude all'instaurarsi della
dittatura fascista, e poi col consolidarsi di
questa, non è certo sperabile veder realizzato ciò
che è stato accantonato per tanto tempo.
A qualche interessante risultato approdava nel
dopoguerra il programma portato avanti dal Partito
Popolare di don Sturzo, che mirava allo sviluppo
della democrazia locale, con l'eliminazione del
clientelismo e della corruzione politica, ed alla
soluzione della questione demaniale con la divisione
del latifondo. Preoccupato di favorire il riscatto
delle masse rurali entro una logica riformatrice, il
« sindacalismo bianco » del Partito Popolare conobbe
notevoli risultati, finché la sua opera non venne
interrotta dall'avvento del regime. Ma sono i
meridionalisti che si riallacciano al Salvemini più
risoluto, a formulare le più interessanti
prospettive. Firmatari nel 1924 dell'Appello ai
meridionali, apparso sulla « Rivoluzione Liberale »
di Gobetti, Guido Dorso e Tommaso Fiore negano la
validità delle riforme isolate, degli interventi
saltuari con cui il potere centrale era solito
concedere di tanto in tanto qualcosa. Secondo loro è
necessario invece impostare diversamente tutta la
politica governativa, sostituire al prepotere delle
vecchie classi dirigenti il decentramento
amministrativo e l'educazione politica delle masse,
perché, rese consapevoli dei propri diritti,
sappiano esprimere la propria classe dirigente,
efficiente e democratica, giungendo da sole alle
trasformazioni sociali di cui necessitano. Solo così
la tanto attesa « rivoluzione meridionale » avrebbe
potuto realizzarsi.
In una visione politicamente più avanzata del
problema e decisamente rivoluzionaria, Granisci nel
1926 addita al proletariato settentrionale il
compito di liberare se stesso dal capitalismo
industriale e la plebe rurale meridionale dal blocco
agrario. Solo un'alleanza tra i ceti sfruttati
avrebbe permesso di sanare la secolare
contrapposizione tra le due Italie, al di là delle
divergenze espresse dagli egoismi delle classi
dirigenti settentrionali e meridionali.
Il Secondo Dopoguerra (1943 – 1950)
1.
L'occupazione dette terre
Una volta crollato il fascismo, nel settembre del
'43, pochi giorni dopo l’armistizio, si verificarono
in Calabria movimenti spontanei di occupazione di
terre. Gli antichi latifondi del Marchesato di
Crotone. grandi feudi dei Berlingieri, Baracco,
Caetani, ecc., venivano invasi da masse di contadini
poveri e di braccianti senza lavoro. Poco più di un
anno dopo, nel 1945, l'occupazione di terre si
estendeva alla Lucania, alla Sicilia, alle Puglie.
Già a metà di quell'anno, l’allora ministro
dell'Agricoltura, il comunista Fausto Gullo, poteva
indicare all'attivo di quel vasto movimento, che
riprendeva con maggiore ampiezza e incisività i moti
per la terra del primo dopoguerra, l'assegnazione
sino ad allora di oltre 170.000 ettari di terra ai
contadini meridionali.
Queste lotte nascevano allora più che dalla
tradizionale aspirazione dei contadini alla terra,
dalla acuta crisi congiunturale post-bellica che si
riversava nelle campagne meridionali sotto forma di
alti prezzi del grano e dalla farina, di
disoccupazione, di inflazione, di penuria
alimentare generalizzata. per i contadini poveri e
per la grande massa dei disoccupati la terra si
presentava quindi immediatamente come l'unico «
bene » in un certo senso a portata di mano, cui
aggrapparsi per sopravvivere. Questo movimento,
nato inizialmente per iniziativa spontanea dei
contadini, venne progressivamente appoggiato e
guidato dal sindacato unitario — la CGIL era stata
ricostituita nel 1944 col Patto di Roma, e
comprendeva cattolici, comunisti e socialisti — che
si era andato rapidamente riorganizzando a livello
nazionale e per categorie, e dai partiti i della
sinistra. Fu proprio l'intervento consapevole delle
forze sindacali, (del PSI e, con più forte presenza
organizzata, del Partito comunista a dare a queste
lotte un carattere meno primitivo e ad arricchirle
di nuovi contenuti rivendicativi. Specie a partire
dal '46, la lotta contadina si estese a nuovi
obiettivi, sindacali e sociali, che coinvolsero
direttamente anche i lavoratori occupati. Sebbene
le occupazioni delle terre rimanessero pur sempre il
centro del movimento, la pressione rivendicativa
toccò anche altri aspetti della condizione sociale
dei lavoratori meridionali e della lotta di classe
nelle campagne. Essa investì l'obiettivo
dell'imponibile di mano d'opera da imporre agli
agrari nelle singole aziende con i relativi impegni
colturali, il controllo sindacale del collocamento
nei comuni agricoli, il rispetto dei salari
contrattuali, il miglioramento dei contratti agrari
a favore dei coltivatori, ecc..
Queste lotte non furono tuttavia un movimento
pacifico e incontrastato. Esse incontrarono un pò in
tutte le regioni del Mezzogiorno la reazione 'feroce
dei ceti agrari cui si accoppiò la repressione da
parte della polizia e dei carabinieri sempre più
dispiegata nelle campagne meridionali, specie dopo
la rottura del Fronte popolare ad opera della DC e
la conseguente esclusione del PCI e del PSI dal
governo. Gli eccidi di Portella della Ginestra —
dove ad un raduno del 1° maggio, nel 1947, gli
uomini del bandito Giuliano spararono sulla folla
dei contadini — di Montescaglioso, di Melissa, sono
in questi anni i nomi esemplari che segnano i
tentativi più brutali, da parte degli agrari e dei
governi centristi, di arrestare il movimento
popolare nelle campagne meridionali.
2. Gli interventi di riforma agraria
La pressione dei contadini meridionali conseguì
comunque dei risultati. Sia attraverso i
provvedimenti di Gullo prima e del democristiano
Segni poi, sia complessivamente attraverso la «
legge stralcio » di riforma fondiaria del 1950, che
comportò insieme ad altre dello stesso anno la
creazione di « enti di riforma » -- quale ad
esempio l'Ente Sila in Calabria — con compiti di
assistenza tecnica e finanziaria ai contadini, fu
allora avviata una parziale trasformazione del
regime fondiario delle campagne. In tutta l'area
meridionale vennero espropriati, in tempi diversi,
circa 417.154 ettari di terra in complesso, che
vennero assegnati ad ex fittavoli operanti sul
latifondo colpito dall'esproprio, a coloni,
contadini poveri, braccianti, ecc..
Nonostante però che queste lotte e la conseguente
riforma intaccasse in più punti la vecchia struttura
agraria meridionale, i suoi risultati finali, da un
punto di vista strettamente sociale, furono
relativamente limitati. Le terre espropriate e date
ai contadini erano in genere le peggiori delle
proprietà colpite dall'esproprio. I vecchi
proprietari, conservarono per lo più il grosso ed il
meglio delle loro terre. Al tempo stesso costoro
venivano ora a beneficiare dei soldi pagati dallo
Stato sotto forma di indennizzo per l'esproprio
subito: soldi che, teoricamente, essi avrebbero
dovuto impiegare ora sulle terre rimaste di loro
proprietà e che erano le più suscettibili di
sviluppo agricolo.
La riforma che avrebbe dovuto formare per un verso
la piccola proprietà contadina e per un altro dare
impulso al vecchio proprietario, nel tentativo di
trasformarlo in imprenditore capitalista, sortì solo
in parte i risultati desiderati. Tanta parte della
piccola proprietà contadina nata dagli espropri,
dopo un certo numero di anni, si trovò ben presto
emarginata e incapace di contrastare, a tutti i
livelli, il potere economico e politico degli
agrari. Mentre questi ultimi solo in parte e in
alcune zone si trasformarono in capitalisti: ma
conservarono tuttavia, per lo più, la vecchia
mentalità reazionaria del passato.
Qualcosa di nuovo emerse e parecchio di vecchio
rimase nelle campagne meridionali: ma la riforma
deluse, in complesso, per i limiti in cui fu
attuata, e per i conseguenti risultati che diede,
quanti vi avevano visto la premessa per uno sviluppo
autonomo autopropulsivo dell'Italia meridionale.
Anche se non mancò l'incremento di produzione
agricola ricercato dalle forze governative, un
effetto comunque indubbio di queste trasformazioni
avvenute nell'agricoltura fu l'allargamento del
mercato meridionale per i monopoli industriali del
Nord, quali la Fiat, la Montecatini, ecc, che in
un'area agricola meno arretrata che in passato
poterono collocare i loro prodotti in macchine
agricole, trattori, concimi chimici, fertilizzanti e
così via.
Lo squilibrio Nord-Sud entrava in una fase nuova, ma
proprio in questo momento rafforzava in modo
definitivo il suo carattere autodinamico, che cioè
si autoalimenta con lo sviluppo economico generale:
più esattamente, con lo specifico modello di
sviluppo capitalistico italiano.
3. La Cassa per il Mezzogiorno
Nel 1950, dopo che la CGIL, sotto la guida di
Giuseppe Di Vittorio (1892-1957), aveva lanciato a
livello nazionale il Piano del lavoro per
incanalare le rivendicazioni popolari --
soprattutto la vasta domanda di occupazione
presente allora nel Paese — in un nuovo e organico
piano di sviluppo generale, veniva istituita la
Cassa per il Mezzogiorno. Nelle intenzioni del ceto
dirigente, dominato dalla DC, il nuovo istituto
pubblico doveva servire a creare le condizioni di
carattere infrastrutturale (costruzione di strade,
porti, canali, ecc.) perché i privati, cioè gli
imprenditori del Nord e del Sud trovassero
convenienza a investire nell'Italia meridionale.
Attraverso gli investimenti annuali dello Stato si
cominciò così ad attuare con la Cassa quella che gli
esperti definirono la fase di «
pre-industrializzazione » del Mezzogiorno. Fase che
— sempre secondo la periodizzazione dei
programmatori — vedrà la propria conclusione nel
1957, quando i progetti di sviluppo assumeranno una
direzione più decisamente rivolta all'incremento
delle strutture industriali in quanto tali.
In realtà la Cassa, in questa fase, non andò oltre
la vecchia logica delle « opere pubbliche »: cioè
quella stessa che aveva orientato i governi
riformisti dell'età giolittiana e, in un certo
senso, gli interventi della bonifica fascista. Essa
creava fonti di occupazione temporanea di masse
senza lavoro: ubbidendo non ad un piano selezionato
e orientato rigorosamente alle finalità effettive
dell'industrializzazione, ma piegandosi nella
sostanza, alle pressioni e agli interessi delle
clientele locali e dei vecchi e nuovi gruppi di
potere che si erano andati ricomponendo dopo la
guerra, specie nelle città. L'intervento
straordinario per il Mezzogiorno si incontrava così
con gli interessi dei ceti possidenti del Sud: i
quali, di fronte al denaro pubblico, cambiarono
solo forma e luogo al loro modo di essere sociale e
alla loro iniziativa economica. Essi cioè, per lo
più, da semplici percettori di rendita agraria si
trasformarono in speculatori edili e finanziari
trasferendo definitivamente o parzialmente il loro
danaro dalla campagna alla città. Parallelamente,
grazie all'istituto della Cassa, incomincia a
verificarsi l’assorbimento politico da parte della
DC dei ceti borghesi meridionali, prima legati ai
vecchi partiti reazionari e monarchici: e nello
stesso tempo viene in questi anni fondato quel
blocco di potere tra gruppi sociali
dominanti-DC-clientela popolare-stato
imprenditoriale che caratterizzerà la vita pubblica
meridionale fino ai giorni nostri.
4. La nuova emigrazione
La mancanza cronica di occupazione nelle città, che
si andavano anche gonfiando demograficamente,
l'assenza di uno sviluppo industriale (mal
sostituito dalle alterne vicende dell’industria
edilizia), la crisi in cui cadeva progressivamente
la piccola proprietà contadina, costituirono le
ragioni di fondo, a metà degli anni '50, della nuova
ondata migratoria delle masse lavoratrici
meridionali. Dapprima orientata verso le zone
industriali dell'Europa, la nuova massa di emigranti
andò progressivamente spostandosi verso le regioni
del nostro « triangolo », man mano che queste si
espandevano richiamando nuova forza lavoro. Questo
grande spostamento di masse dal Sud al Nord del
Paese, dalla campagna alla città, che trasferì
annualmente centinaia di migliaia di individui,
percorrerà in forme socialmente drammatiche anche il
decennio successivo, gli anni '60, e segnerà
profondamente una fase dello sviluppo nazionale.
L'emigrazione meridionale può oggi essere
considerata quale uno degli elementi fondamentali
della strategia dello sviluppo capitalistico nel
dopoguerra in Italia. Quella strategia di politica
economica che gli economisti e i tecnici del ceto
politico governativo definirono di «
liberalizzazione », e che coincise col libero
scambio di merci e forza lavoro a livello
internazionale in condizioni di mercato favorevoli
all'Italia. Soprattutto dopo la sconfitta subita
dalla classe operaia e dal movimento sindacale di
classe a metà del decennio '50, l'emigrazione
meridionale al Nord s'inserisce in un modello di
sviluppo determinato che è ad un tempo un fatto
politico oltre che economico. Essa infatti assolve
al duplice compito di portare forza lavoro a basso
costo nella fabbrica, e di comprimere i salari e la
combattività della massa operaia già occupata. Si
creano così le condizioni politiche ed economiche
preliminari del disegno capitalistico di questi anni
che porterà al boom degli inizi del nuovo decennio.
Infatti i bassi costi dei prodotti nazionali che
vengono vantaggiosamente smerciati all'estero —
ottenuti grazie allo sfruttamento intensivo del
lavoro vivo dell'operaio e ai bassi salari — si
combinano con l'intervento straordinario nel
Mezzogiorno: il quale non frena l'emigrazione, non
intacca i nodi strutturali di quella società, ma nel
frattempo usa il denaro pubblico per legare nuovi e
vecchi ceti al potere politico e al tempo stesso per
allargare « artificialmente » il mercato interno e
la domanda di beni dei prodotti capitalistici che
non raggiungono i mercati esteri.
5. Nuove problematiche meridionalistiche
La pubblicazione nell'immediato dopoguerra dei
Quaderni dal carcere di Gramsci, e segnatamente
degli scritti su Il Risorgimento (1950), la nuova
lotta sindacale e politica che si era aperta nel
Mezzogiorno e insieme i nuovi fenomeni di
trasformazione e di abbandono che lo percorrevano,
fecero convergere l'attenzione storica e teorica di
non pochi intellettuali militanti sui nuovi termini
in cui si poneva la questione meridionale. Due
studiosi merita ricordare: Emilio Sereni e Manlio
Rossi Doria. Il primo, sotto una angolazione
marxista e leninista maturata ancor prima della
caduta del fascismo, proponeva nel 1947 un suo
studio II capitalismo nelle campagne
(1860-1900), in cui veniva ricostruita la vicenda
dell'agricoltura nazionale nel primo quarantennio
di storia unitaria, e i caratteri particolari della
penetrazione del capitalismo italiano in quelle
strutture feudali e semi-feudali. Nel suo lavoro,
preminentemente storico, Sereni metteva tuttavia qua
e là in evidenza la constatazione, e insieme l’idea
di fondo che lo ispirava, di quanto la mancata
trasformazione fondiaria delle campagne, soprattutto
nel Sud, avesse ostacolato l'espansione in senso
capitalistico moderno dell'agricoltura. Una tesi
questa che era destinata ad incontrarsi e talora
anche ad essere, non correttamente, assimilata a
quella propria di Gramsci secondo cui una mancata
rivoluzione contadina era alle origini del distorto
sviluppo capitalistico nazionale. Con Vecchio e
nuovo nelle campagne italiane, del 1956, Sereni
tracciò un critico bilancio delle trasformazioni
avvenute nelle campagne del Paese dai movimenti del
dopoguerra ad allora, mettendo in evidenza la nuova
subordinazione a cui l'agricoltura, specie quella
meridionale, veniva a soggiacere nella nuova fase
dello sviluppo nazionale: quella del capitalismo
monopolistico e finanziario.
Manlio Rossi Doria, che già nel 1944 era stato,
insieme a Dorso e ad altri Esponenti del Partito
d'azione, uno dei promotori di un importante
convegno tenuto a Bari sulla questione meridionale,
pubblicava poco tempo dopo, nel 1948, la raccolta di
saggi Riforma agraria e azione meridionalista.
In essa — così come in altri successivi lavori
pubblicati nel corso degli anni '50 e '60 — Rossi
Doria si faceva allora portatore di una conoscenza
viva e diretta della struttura agricola meridionale,
mettendone in evidenza i limiti naturali e avanzando
proposte di riforma agraria che volevano tener
conto della multiforme realtà del mondo contadino
del Sud. Le sue proposte puntavano cioè ad esaltare
nuove forme di proprietà, piccole e medie, in grado
a un tempo di rinnovare se stesse e le antiche
proprietà borghesi che avrebbero dovuto essere
percorse da un nuovo dinamismo. La lottizzazione del
latifondo fra i contadini poveri, o la proposta
della « collettivizzazione » delle terre gli
apparivano, per il mondo agricolo meridionale,
delle linee di riforma non suscettibili di provocare
sviluppo oppure irreali e impraticabili. Un
contributo critico al dibattito tradizionale sulla
questione del Mezzogiorno venne dai saggi della
studiosa inglese Vera Lutz, pubblicati sulla rivista
Moneta e credito nel 1956 e nel 1958, e su
Cronache meridionali nel 1962. La sua analisi
delle caratteristiche dualistiche dell'economia
italiana, e in particolare del mercato del lavoro,
concludeva con una previsione di sviluppo
tendenzialmente divaricante.
Su un altro versante si colloca l'azione di Danilo
Dolci, che si dedicò a una vasta opera d'indagine
sociologica (Inchiesta a Palermo, 1956), e di
denuncia « non violenta » delle intollerabili
condizioni di vita delle popolazioni siciliane.
Un accenno qui merita anche Tommaso Fiore_ autore di
Un popolo di formiche (1951) che riproponeva
una forte denuncia delle condizioni della ) società
meridionale e in particolare la situazione delle
Puglie, che egli aveva analizzato con acutezza nel
momento di trapasso dallo Stato liberale al
fascismo attraverso le colonne di « Rivoluzione
liberale » di Piero Gobetti.
Gli anni ‘60
1. Nuova politica e « poli di sviluppo »
Già nel 1953 vi erano stati tentativi da parte del
governo volti a incrementare alcune iniziative
industriali nel Mezzogiorno. La linea fu quella di
favorire il finanziamento delle attività industriali
meridionali attraverso speciali istituti di credito
quali ISVEIMER, l'IRFIS, ecc. Ma fu solo nel 1957
che ebbe inizio quello che fu definito dai «
programmatori » il secondo tempo della politica
meridionalistica di parte governativa. Si trattava
cioè questa volta di un impegno diretto dello Stato
a favore dello sviluppo industriale nel Sud
attraverso gli investimenti delle aziende a
partecipazione statale accoppiati alle agevolazioni
creditizie, fiscali, ecc., ai privati che
intraprendevano iniziative industriali nel
Mezzogiorno. Questa linea di intervento puntò
decisamente alla creazione di alcune isolate aree
industriali, privilegiando in questo i grandi
complessi di base, siderurgici e petrolchimici.
Nuclei industriali di notevoli dimensioni furono
allora insediati a Tarante, Brindisi, Gela,
Siracusa, ecc. anche coll'implicita convinzione dei
programmatori che queste nuove concentrazioni erano
oggettivamente destinate a funzionare da « poli di
sviluppo » per le aree sociali e geografiche
circostanti. Queste ultime, cioè, avrebbero dovuto
essere spontaneamente coinvolte in un
processo generale di industrializzazione « indotta
».
I « poli », immisero nuovi capitali, pubblici e
privati, nella società meridionale e contribuirono
indubbiamente a romperne in più punti il vecchio
assetto preminentemente agrario. Concentrazioni
operaie e nuove forme di occupazione industriale si
realizzavano per la prima volta in queste regioni.
Tuttavia i poli non provocarono lo sviluppo indotto
che si era sperato e l'irradiamento spontaneo della
industrializzazione al resto del Mezzogiorno. In
realtà, sia nella localizzazione, sia nel tipo di
investimento, sia nella scelta del settore, questi
interventi ubbidirono essenzialmente agli interessi
privati delle industrie del Nord e dei grandi gruppi
capitalistici e finanziari: non erano cioè ispirati
a una pianificazione organica, industriale e
territoriale, dello sviluppo del Sud, ma orientati,
nella sostanza, dagli interessi di allargamento e di
sviluppo dei settori dominanti del capitalismo
nazionale.
II limite di fondo di questo tipo di strategia
dell'industrializzazione fu nella sua caratteristica
preminente di aggiunta quantitativa di realtà
industriale al Sud agricolo: senza una profonda
modificazione qualitativa del meccanismo di
sviluppo, che oggettivamente alimentava lo
squilibrio Nord-Sud, e che finiva col sottomettere
alla sua logica dominante anche questo tentativo
istituzionale di modificazione.
2. Un nuovo sottosviluppo
II decennio '60 consuma tuttavia un processo di
modificazione profonda della società meridionale.
Alcune aree come quella di Napoli, di alcune zone
della Puglia, della Sicilia orientale, ecc. vanno
sempre di più caratterizzandosi in senso
industriale. Cresce relativamente il numero degli
addetti all'industria, mentre fra il 1961 e il 1971
gli addetti all'agricoltura passano da circa 2
milioni e 800 mila a 1 milione e 700 mila circa.
Intere zone delle campagne sono nel frattempo
lasciate in abbandono e si sviluppa con particolare
intensità il fenomeno delle migrazioni interne. Lo
spostamento dalla campagna trasferisce migliaia di
famiglie nelle città meridionali le cui strutture
si gonfiano a vista d'occhio, senza piani
regolatori, senza controlli delle Amministrazioni
comunali, sotto l'iniziativa sfrenata della
speculazione edilizia che in questi anni celebra il
culmine delle proprie fortune. È anzi in questa
fase che i gruppi sociali legati ad essa, sotto
la protezione, la
connivenza e talora anche l'intreccio col ceto
politico dirigente locale e nazionale, si
costituiscono quali nuovi centri di potere nella
realtà meridionale.
Nel frattempo, allo stesso modo abnorme in cui si
sviluppano le città — senza cioè una minima
programmazione territoriale legata ad effettive
esigenze di sviluppo economico — si gonfiano sino
alla distorsione i settori del cosiddetto terziario,
costretto ad assorbire la domanda di lavoro di una
città che cresce su se stessa e non su una reale
dinamica di produzione e di sviluppo. È soprattutto
la Pubblica amministrazione che a livello
occupazionale si sostituisce di fatto alle mancate
fonti di lavoro nel settore industriale e nei
servizi. Ed è soprattutto qui che i gruppi dirigenti
locali del Mezzogiorno dirottano, attraverso il «
filtraggio » clientelare, l'inesauribile domanda di
occupazione che viene dai ceti proletari e
sottoproletari e dai ceti medi. Basti qui menzionare
a mo' di esempio — in una situazione generale del
Mezzogiorno che pure ha visto aumentare il suo
reddito procapite sia pure in forme ancor più
squilibrate rispetto al Nord — una rilevazione
SVIMEZ, relativa alla situazione del reddito
meridionale al 1971, che assegna al « reddito »
complessivo prodotto nella Pubblica amministrazione
il 33,5% rispetto a quello nazionale e soltanto il
19,3% per le attività industriali, comprese le
attività terziarie private! Il sottosviluppo
meridionale cambia dunque volto, dominato com'è
ormai dalla realtà della « sovraurbanizzazione », da
città gremite di impiegati e di disoccupati. E la
fonte dello squilibrio Nord-Sud si rialimenta ora
per l'esistenza di un ceto medio pletorico e
parassita e di altre realtà di intermediazione e
speculative che divorano le risorse prodotte
localmente e insieme quelle « che la collettività
trasferisce al Sud per favorirne lo sviluppo ». (P.
Saraceno).
3. Il meridionalismo degli anni '60
Non manca in questo decennio l'interesse di singoli
e di gruppi per i problemi del Mezzogiorno che ora
vengono esaminati, in maniera che si può definire
esclusiva, nei loro oggettivi riferimenti con le
sorti dello sviluppo nazionale. C'è ovviamente chi
interviene nel dibattito per negare nella sostanza
l'esistenza di un « problema dello sviluppo », per
affermare cioè che solo un'ulteriore espansione
dell'economia del Nord può risollevare il Sud. Ma
nella sostanza la riflessione meridionalistica, con
le sue diverse posizioni e collocazioni, non può non
registrare i termini sia pur rinnovati di una
persistente contraddizione nello sviluppo
capitalistico italiano.
Così è ad esempio per Pasquale Saraceno, presidente
della SVIMEZ, la Società per lo sviluppo del
Mezzogiorno fondata a Roma nel 1946 da studiosi
privati che ha dato nel corso di questi anni
notevoli contributi di conoscenza scientifica della
società meridionale, fornendo periodicamente
aggiornamenti statistici e di riflessione sui suoi
mutamenti interni. Saraceno è un acuto osservatore
dei meccanismi economici che presiedono al rapporto
Nord-Sud e alla sua dinamica ed è stato, fin dal
dopoguerra e per tutti gli anni successivi, con
posizioni di influenza a livello istituzionale, un
sostenitore strenuo della decisività
dell'industrializzazione nella soluzione della
questione meridionale.
In una direzione « industrialista », ma animata da
umori politici più vivaci e polemici si muove per
tutto il decennio la rivista « Nord e Sud ».
Animata per lo più da figure come Giuseppe Galasso.
storico del Mezzogiorno e della popolazione
meridionale, da economisti come Manlio Rossi Doria,
da osservatori della realtà meridionale e
soprattutto napoletana, come Francesco Compagna,
essa aveva pubblicato sul finire degli anni '50
alcuni articoli del liberale Rosario Romeo che
costituirono per diverso tempo la polarizzazione
costante del dibattito meridionalistico. La tesi
sostenuta sostanzialmente dallo storico siciliano
era - - in netta opposizione alla tesi gramsciana
sulla mancata rivoluzione contadina sostenuta in
vario modo dalla storiografia marxista — l'asserita
necessità, al momento della formazione dello Stato
unitario e nei decenni successivi, del « sacrificio
» dei contadini, soprattutto meridionali: cioè della
necessità di comprimere i loro consumi e il loro
livello di vita per far sorgere e sviluppare nelle
regioni nel Nord una moderna realtà industriale. La
polemica divampò allora su questo problema
raggiungendo a volte toni anche molto aspri. Ma essa
fu anche occasione di nuovi studi storici sul
Mezzogiorno e sulla questione meridionale,
contribuendo a creare, al contempo, il nuovo clima
culturale in cui viene ripubblicata l'Antologia
della questione meridionale, (1962) di Bruno
Caizzi, Rosario Villari pubblica II Sud netta
Storia d'Italia (1961), la SVIMEZ sistema i «
dati statistici sulla questione meridionale » con
il volume Statistiche sul Mezzogiorno d'Italia
(1861-1960), Saraceno pubblica il suo saggio
miscellaneo, La mancata unificazione economica
italiana a cento anni dall'unificazione politica (
1961 ); Romeo aveva dato alle stampe
Risorgimento e capitalismo (1959). « Nord e Sud
» ovviamente non si identificava con le posizioni
del Romeo, ma nella sostanza perseguì una visione
tecnocratica dei problemi del Mezzogiorno; fiduciosa
cioè che la razionalità tecnica di una buona
politica governativa di intervento per
l'industrializzazione avrebbero potuto risolvere
positivamente i problemi dello « squilibrio
nazionale ». Sempre a livello di gruppo informale o
di singolo ricercatore vanno qui almeno menzionati
studiosi quali Nino Novacco, Nicola Cacace, ecc.,
facenti parte del cosiddetto « Gruppo dei
meridionalisti di Bari », che conducono ricorrenti
analisi sull'evoluzione dell'attuale realtà
meridionale, sia attraverso i canali della SVIMEZ,
sia attraverso interventi su « Mondo economico »,
ecc..
4. Il meridionalismo di massa
Ma accanto all'attività conoscitiva o ideologica di
singoli personaggi o di gruppi intellettuali più o
meno organizzati, va fatta menzione di un'altra
attività « meridionalistica » di ben più vaste
dimensioni e di più profonda incisività materiale.
Si tratta innanzi tutto di quello che possiamo
definire il « meridionalismo di massa » implicito
nell'attività del sindacato. Esso infatti in
Italia, sin dall'immediato dopoguerra, aveva svolto
un ruolo specifico ma socialmente rilevante in
favore delle masse lavora-trici meridionali: grazie
al conseguimento di contratti nazionali per le
diverse categorie, l'unificazione normativa e
assistenziale, ecc., e tutta una serie di altre
conquiste - - strappate grazie soprattutto al
maggior peso politico della classe operaia del Nord
- - che andavano a beneficio anche della povera e
disgregata classe operaia del Sud, contribuendo ad
un tempo a migliorare la situazione sociale
complessiva del Mezzogiorno. Ma esiste anche un
impegno meridionalistico diretto del
sindacato, che non è certo meno importante. Proprio
agli inizi degli anni '60, in concomitanza con la
ripresa delle lotte operaie nel Paese, il movimento
sindacale riprende direttamente la problematica e
l'impegno meridionalistico. Nella primavera del '60,
la CISL organizza un Convegno sull'azione sindacale
nel Mezzogiorno per individuare i nuovi compiti del
sindacato a dieci anni della politica di intervento
dello Stato nel Sud. La CGIL tiene la sua prima
Conferenza meridionale nel 1961, in cui vengono
messi a punto errori e debolezze del passato e viene
ad un tempo compiuto un notevole sforzo di
conoscenza e di aggiornamento dei dati nuovi che
caratterizzano la società meridionale. Segue a
questa la 2a Conferenza meridionale,
tenuta a Bari nell'estate del '63 e infine la 3a
Conferenza, svoltasi a Palermo nel dicembre del '65.
Quest'ultima costituisce un importante passo in
avanti nell'elaborazione meridionalistica della
CGIL, perché essa coglie con più forza che in
passato il legame fra strategia generale del
sindacato nei confronti delle masse lavoratrici e
questione del Mezzogiorno. Nella consapevolezza che
« gli aspetti più gravi della situazione italiana
investono contemporaneamente, anche se in modo
diverso, tutti i lavoratori italiani » essa punta a
concepire i problemi meridionali in una visione
sempre meno settoriale e in cui fortemente viene
sottolineata « l'unità sostanziale degli interessi e
degli obiettivi di lotta dei lavoratori in tutto il
Paese ».
Il momento di riflessione e di elaborazione non
resta comunque il solo dell'iniziativa
meridionalistica del sindacato negli anni '60.
Proprio sul finire del decennio, dopo un periodo di
serio allentamento nel rapporto fra iniziativa
sindacale e problema meridionale, l’impegno unitario
delle tre Confederazioni nazionali rilancia con una
lotta di massa una fase nuova di intervento del
sindacato nel Mezzogiorno. E' la lotta contro le «
gabbie salariali », cioè per l'equiparazione dei
salari contrattuali del Sud a quelli degli operai di
Milano e delle altre regioni del Nord. E una grande
rivendicazione di classe e sociale, che unisce
veramente il Nord e il Sud nella lotta contro una
odiosa discriminazione e nello stesso tempo tende a
unificarli su un fatto di principio. Per l'esito
vittorioso di quella lotta, che gli operai
meridionali intrapresero con straordinaria
partecipazione di massa, il sindacato chiamò alla
solidarietà di classe il determinante intervento
dell'intero schieramento operaio dell'Italia
settentrionale. Nella stessa dimensione politica di
massa va qui collocato l'impegno meridionalistico
dei partiti della sinistra, del PSI e del PCI. In
questo caso il meridionalismo si traduce in una
complessa attività intellettuale e pratica che
unisce all'analisi la proposta politica, alla
conoscenza sociologica la divulgazione fra le masse,
alla critica dello stato presente della realtà
meridionale le indicazioni per l'intervento politico
concreto e riformatore. (Per il PCI l'impegno
meridionalistico ha anzi costituito un momento
specifico di impegno scientifico e culturale,
soprattutto con la fondazione della rivista
«Cronache meridionali» (1953), che per più di un
decennio vide impegnate figure di giovani
intellettuali meridionali di sinistra, stimati
perfino da un avversario polemico quale il vecchio
Salvemini). In questi anni la riflessione dei
partiti della sinistra sul Mezzogiorno è
prevalentemente assorbita dal dibattito in corso sui
problemi dell'industrializzazione del Sud. È
soprattutto l'evidente insufficienza dei poli di
sviluppo a trasformare la
società meridionale — così come inadeguata a
risolvere i problemi dello sviluppo appariva già
allora la politica dei socialisti impegnati,
tramite la loro azione di governo, a dotare il Sud
di un vasto impianto di infrastrutture industriali e
civili — che porta gran parte del movimento operaio
ad una critica serrata della politica di intervento
straordinario e al tipo di strategia sin lì
perseguito dalle forze di governo. Le proposte
alternative che scaturiscono da questa impostazione
sono soprattutto tese al conseguimento di una
trasformazione strutturale dell'agricoltura: quale
premessa organica e necessaria di un nuovo tipo di
industrializzazione, che sia più saldamente legato
alla realtà sociale e alle risorse proprie del
Mezzogiorno.
Gli anni ‘70
1. La rivolta di Reggio Calabria
I fatti di Reggio del 1970 e degli inizi del 1971
non sono un semplice incidente provocato dalla
questione del capoluogo regionale, né il semplice
parto provocatorio delle squadre neofasciste che
imperversarono per mesi in quella città. Il
Mezzogiorno era già esploso in più punti e in
differenti realtà sociali: da Isola Capo Rizzuto a
Cutro, da Avola a Battipaglia, esprimendo in forma
di rivolta sociale l'intollerabilità di
contraddizioni che lo sviluppo capitalistico e
insieme la sua assenza o insufficienza vi avevano
prodotto.
Reggio è la città più grande della Calabria: di
quella regione cioè che nel censimento del 1971 ha
visto diminuire del 12,4% i propri addetti
all'industria rispetto nientemeno che al censimento
del 1951! È facile immaginare come le
contraddizioni abnormi delle città meridionali, già
accennate nel capitolo precedente, qui covassero in
una situazione in cui la miseria dei ceti
sottoproletari dei vecchi rioni, il rancore dei
disoccupati stanchi di fare i « clienti » dei
partiti locali, la frustrazione dei giovani senza
prospettive di lavoro avevano da tempo, in modo
latente, reso esplo-siva. Lo stesso obiettivo di «
Reggio capoluogo », il cieco puntiglio
campanilistico che chiamò sulle piazze i diversi
ceti della città, sono da soli, nella loro
assurdità, la conferma della disperazione sociale e
politica cui era pervenuta una intera popolazione. E
solo questo può spiegare il successo di massa
dell'inserimento fascista nei moti e la cinica
strumentalizzazione di notabili locali e dello
stesso sindaco democristiano a cui in quel momento
non veniva chiesto il conto politico del governo
della città in qualità di sindaco e di quello
dell'intero Paese in qualità di democristiano... E
anche vero tuttavia che la debolezza delle
organizzazioni di massa del movimento operaio e la
perdita di consenso popolare --di cui le rivolte
della fine degli anni '60 erano stati « segni »
premonitori -- permisero che le masse popolari
reggine ritenuti ormai inservibili i canali
tradizionali della lotta politica e rivendicativa
per un mutamento della situazione esistente, si
siano lasciate trascinare in una rivolta senza
sbocchi e, alla fine, apertamente reazionaria.
2. Sindacato e Mezzogiorno
La lotta vittoriosa per abolire le discriminazioni
salariali tra gli operai del Nord e del Sud,
favorita sul finire del decennio '60 dai progressi
dell'unità sindacale fra CGIL, CISL e UIL, non
rimane comunque un capitolo isolato dell'impegno
meridionalistico di massa del sindacato. Gli stessi
avvenimenti di Reggio ripropongono semmai
drammaticamente lo acutizzarsi dei problemi
meridionali e la necessità di una più approfondita
riconsiderazione del rapporto Mezzogiorno-sindacato
all'interno delle tre Confederazioni.
Nasce così, sulla spinta dei nuovi fatti politici,
la prima Conferenza sindacale unitaria sui problemi
del Mezzogiorno, che si svolge a Roma nella
primavera del 71 e che è accompagnata da una
imponente manifestazione di lavoratori confluiti da
tutte le regioni d'Italia. Ad essa segue il
Convegno di Bari del febbraio del 72, in cui il
dibattito si concentra essenzialmente sulla
strategia dell'intervento sindacale nel Sud e sulle
prospettive del suo sviluppo. Ma il momento forse
politicamente più significativo di quest'impegno
nazionale del sindacato per il Mezzogiorno è la
Conferenza che si svolge proprio a Reggio Calabria,
la citta sconvolta dai moti dell'anno precedente,
dal 20 al 22 ottobre del 72 e che si conclude con
una straordinaria manifestazione operaia — degli
operai giunti da tutte le regioni del Paese — per le
vie della città. Questa Conferenza,
promossa dalla
Federazione dei metalmeccanici, dagli edili, e dalla
Federbraccianti sarà seguita in dicembre da un
convegno per quadri sindacali organizzato dalle tre
Confederazioni a Napoli, che ha al centro la messa a
punto delle strategie rivendicative da perseguire
per lo sviluppo del Mezzogiorno.
Questo insieme di impegni organizzativi, e a un
tempo di iniziative a livello di analisi e di
elaborazione, segnano un momento assai importante e
nella crescita specifica del movimento sindacale in
Italia e — per quello che qui ci interessa — nella
storia dell'analisi del Mezzogiorno e dell'impegno
meridionalistico. Nella riflessione del sindacato i
problemi attuali della società meridionale
tendono ad identificarsi sempre di più con i
problemi dell'intero sviluppo del Paese: II Sud non
è il luogo fisico del mancato sviluppo —
presso cui cioè sarebbe sufficiente intervenire con
strumenti di puro riequilibrio economico — ma è ad
un tempo eletto e funzione di un modo
storicamente determinato di produrre la ricchezza,
di utilizzare le risorse, di organizzare la vita
sociale dell'intera collettività. E nello squilibrio
del Mezzogiorno all'interno della generale crisi
nazionale di questi primi anni 70 è la denuncia
oggettiva, per il sindacato, dell'esaurimento di un
modello storico di accumulazione, quello fin
qui perseguito dal capitalismo italiano con
l'ausilio dell'intervento e della mediazione
statuale. Ma l'elaborazione meridionalistica del
sindacato non si ferma né si esaurisce nell'analisi
e nella denuncia di quanto di negativo e di distorto
è nello sviluppo attuale e nelle sue conseguenze
dentro la società meridionale. Essa punta
invece, contestualmente, più che nel passato,
a indicare in positivo le linee alternative
da seguire, le cose concrete da chiedere e da fare.
È proprio al Convegno di Napoli che le
Confederazioni elaborano la proposta di un «
progetto globale », in cui le indicazioni relative
al Mezzogiorno si intrecciano con le proposte
concrete di un nuovo modello di sviluppo,
perseguibile attraverso le riforme e un nuovo
orientamento verso i consumi sociali. Nel documento
conclusivo di quel Convegno si dichiara: «
L'azione per le riforme deve costituire momento
fondamentale della nuova strategia di sviluppo. Non
si tratta tanto di proporre un'astratta
meridionalizzazione delle riforme, ma di cogliere
in concreto i nessi e le interdipendenze fra la
domanda pubblica di case, scuole, ospedali,
trasporti e le occasioni di allargamento della base
produttiva e quindi dell'occupazione al Sud, di
qualificazione e rafforzamento dell'intero
apparato produttivo, in seguito al superamento
degli squilibri settoriali e territoriali ».
Nel segno di questa nuova consapevolezza teorica e
politica, la vertenza aperta dalla Federazione
lavoratori metalmeccanici (FLM) con le
Partecipazioni statali e l'impegno nelle lotte
aziendali degli operai del Nord per nuovi
investimenti industriali nel Mezzogiorno
rappresentano sino ad ora, con tutti i loro limiti —
impliciti soprattutto nella capacità di traduzione
di queste indicazioni in termini di orientamento e
di lotta nelle organizzazioni meridionali del
sindacato — il momento importante e significativo
del nuovo meridionalismo di massa degli anni ‘70. |
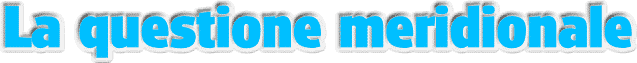
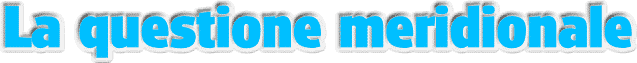
![]()